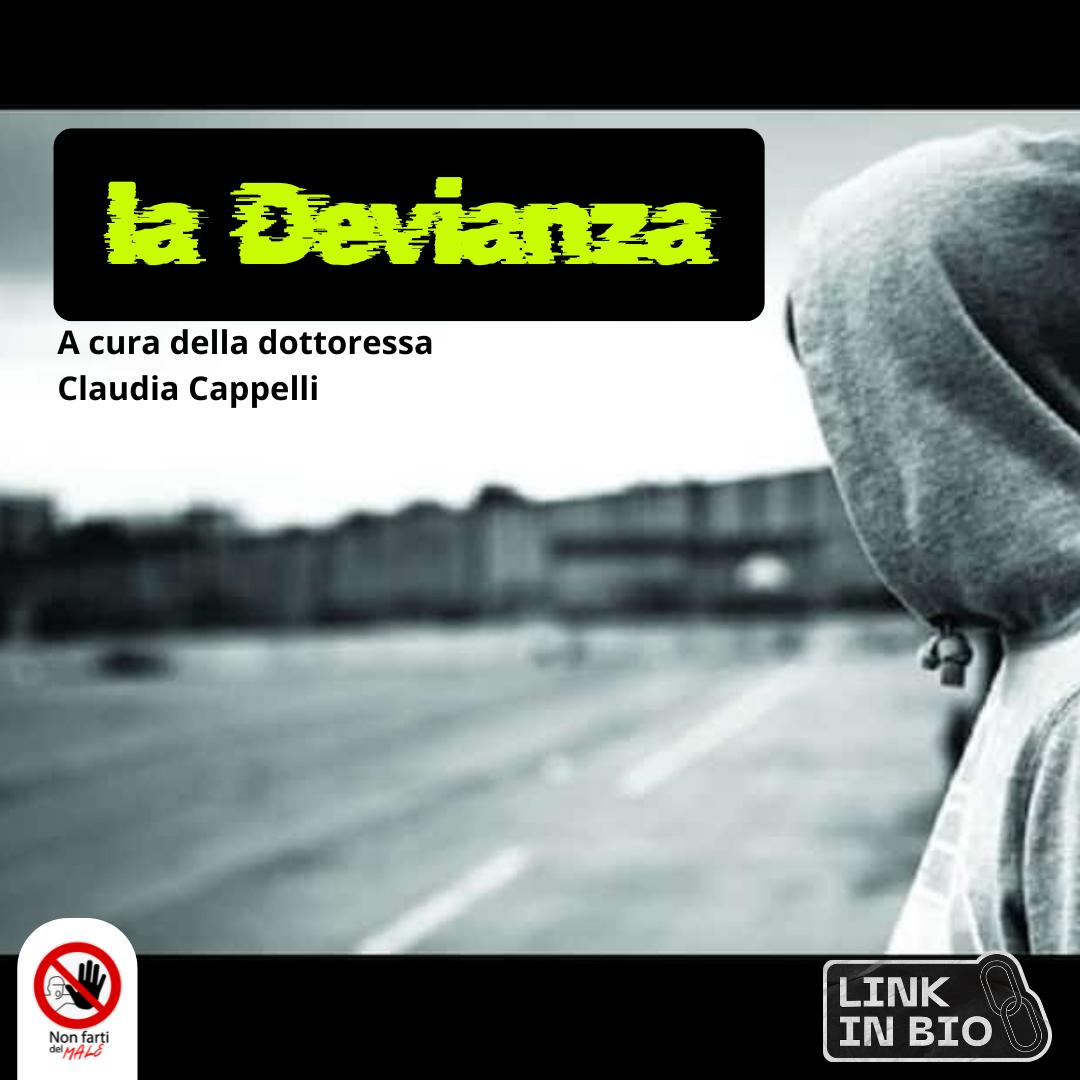
Autore: Claudia Cappelli
| 8 Settembre, 2025
Definizione e origini
Per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che collide con la struttura etica o dominante di una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di disapprovazione, condanna o discriminazione.
Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per la risposta che suscita nell’ambiente socioculturale in cui ha luogo. La devianza è uno dei campi della sociologia che presenta maggiori difficoltà nella fase di ricerca scientifica, dal momento che i reati ufficiali sono solo una piccola parte dei reati realmente commessi, quindi si avranno solo dati approssimativi e teorici di un fenomeno che non può essere studiato nella sua totalità (per esempio esistono i cosiddetti “reati senza vittima”, come la prostituzione o il consumo di stupefacenti o il gioco d’azzardo, di cui non si conoscono con esattezza le statistiche e quindi la ricerca scientifica in questi casi potrà solamente formulare teorie approssimative).
Come sostiene E. Durkheim : “Non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo”.
Le risposte della collettività a uno stesso atto variano nello spazio e nel tempo: per questo motivo si parla di “relatività” dell’atto deviante rispetto a:
- contesto storico/politico/sociale;
- ambito geografico;
- situazione.
Perciò possiamo concludere che un atto può essere considerato deviante in riferimento al contesto socioculturale in cui ha luogo ovvero può non esserlo in altri contesti nell’ottica di un relativismo etico-culturale e in linea di massima mutare con l’evolversi della società stessa.
Esistono sette principali teorie, elaborate da studiosi, sociologi ed economisti, che esplicano perché alcune persone tendono a commettere atti devianti.
Le teorie sono le seguenti:
- Teoria biologica: Tale teoria sostiene che la criminalità è legata a determinate caratteristiche fisiche di un individuo.
Uno dei primi studiosi di questa teoria, Cesare Lombroso, descrive il “delinquente nato” con una serie di peculiarità (testa piccola, sopracciglia folte ecc.). Egli considerava la morfologia del fisico, e del viso in particolare, come la principale causa di criminalità. Lombroso fece degli studi sui cadaveri di prostitute, folli e criminali, all’interno del gabinetto di medicina legale di Via Po, Torino. Nel 1859, in occasione della seconda Guerra d’Indipendenza, ebbe l’opportunità di studiare cervelli e crani dei soldati caduti in battaglia.
I medesimi studi furono compiuti su deceduti dei manicomi di Pavia e Pesaro. A seguito dei suoi studi Lombroso ha elaborato tale teoria, secondo tali studi i delinquenti si differenziavano per la presenza di anomalie fisiche di natura atavica.
Per questo elaborò la «teoria del delinquente nato», per cui i delinquenti erano riconoscibili per anomalie somatiche tipiche e caratteristiche come ad esempio : orecchie grandi, fronte alta, naso storto, sopracciglia folte, alto tasso di pigmentazione della pelle e assenza di rimorso, crudeltà, vanità.
Stimò che il 70% dei criminali rientrava nella categoria; ma a seguito dell’introduzione di fattori psicologici e sociali , non tenuti in considerazione prima, la percentuale si abbassò al 35%. - Teoria della tensione: Spiega come la devianza sia indotta dall’anomia, ovvero la mancanza di norme sociali che regolano e limitano i comportamenti individuali (Durkheim).
Robert Merton aggiunge un qualcosa in più alla teoria del sociologo francese: l’anomia riscontrata nei soggetti considerati devianti dipende dagli obiettivi che un soggetto si prefigge e dai mezzi che ha a sua disposizione per perseguirli, sia che questi ultimi siano culturali, che sociali, che economici. Dunque la devianza fosse provocata da un contrasto fra la struttura sociale e quella culturale.
L’individuo che ha i mezzi, economici e non solo, anche relazionali ad esempio, avrà un percorso più lineare e conforme che lo porterà ad avere il tanto agognato successo economico.
Viceversa chi non può permettersi di accedere a determinati servizi, come l’istruzione ad esempio, potrebbe comunque non voler rinunciare all’obbiettivo di arricchirsi e utilizzare altri mezzi, spesso non leciti, come rubare.
L’atto deviante viene spiegato secondo Merton dal voler raggiungere a tutti i costi un obbiettivo non personale, ma imposto dal proprio ambiente esterno. - Teoria del controllo sociale: Il maggior esponente di questa particolare teoria è Travis Hirschi.
In questo particolare caso non si studia ciò che porta una persona a deviare, ma cosa spinge la maggior parte della società a non farlo e quali sono i controlli a livello sociale che impediscono la violazione di norme.
La teoria del controllo sociale si basa sulla capacità delle sanzioni interne ed esterne di impedire alle persone di deviare. - Teoria della subcultura: Edwin Sutherland esplica come l’isolamento sociale di certi individui costituisca una subcultura criminale con norme e valori differenti rispetto a quelli della società istituzionalizzata.
Da tale ambiente ne deriveranno per forza individui devianti, che hanno appreso comportamenti poco consoni alla società tramite la comunicazione con altre persone, che a loro volta porteranno tali deviazioni nella società dalla quale erano stati esiliati. - Teoria dell’etichettamento: Per capire la devianza bisogna considerare anche l’aspetto della creazione delle norme e la relativa applicazione rispetto ad una certa violazione.
Una persona considerata deviata sarà etichettata come tale, di conseguenza tramite la mancata accettazione da parte della società e l’isolamento la reiterazione della devianza sarà ovvia. - Teoria della scelta razionale: gli esponenti di tale tesi sostengono che la volontà dell’individuo sia determinante: una persona ha la libertà di scegliere se violare o meno la norma. In quest’ ottica risulta facile capire la frase del celebre criminologo giapponese Hiroshi Tsutomi: “Le persone commettono reati non perché sono patologiche e malvagie, ma perché sono normali”.
Numerose sono le teorie alla base delle devianze, altrettanti sono i tipi di devianza.
Possiamo trovare la devianza criminale, culturale, economica, devianza intesa come disturbi mentali, devianza di tipo sociale e infine quella tecnologica (meglio conosciuta come cyberbullismo).
Devianza e sessualità
Usato spesso indicando così varie forme di perversione sessuale. Molto cospicui sono gli studi sulla correlazione fra devianza, traumi, autolesionismo, attaccamento e abusi.
Dalla letteratura psicologica e psichiatrica si evince come, al di là dei complessi profili psicologici degli interessati e delle motivazioni profonde che li possono condurre alla devianza sessuale, le pratiche di perversione sessuale sono più spesso frequenti in soggetti di tipo borderline.
In particolare, l’individuo che sceglie di assoggettarsi a pratiche sessuali devianti, ad esempio di masochismo, risulta mosso da un comportamento psicologico la cui causa emotiva è, a sua volta, il senso di colpa.
Robert K. Merton pensa che la devianza nasca dalla “tensione” attraverso cui non si riesce a raggiungere il successo sociale; droghe e disturbo mentale sono perciò forme di “adattamento deviante”.
Freud e diversi autori hanno cercato di spiegare i fenomeni criminali in termini di “psicopatia”, “degenerazione” e in generale come legati a problemi di ordine psichico.
Spesso questi studiosi hanno cercato di rintracciare la causa della devianza in situazioni familiari patogene relative all’infanzia del soggetto.
In considerazione di ciò, il comportamento delinquenziale non sarebbe altro che l’espressione sintomatica delle tensioni provocate da situazioni familiari pregresse e mai superate dal soggetto.
Nonostante la pluralità dei modelli interpretativi, la maggioranza delle indagini condotte in questo campo tende a ricondurre le radici della devianza a conflitti non risolti, a processi di identificazione psicologica, a meccanismi reattivi ecc. accaduti in particolari situazioni dell’infanzia e dell’adolescenza del soggetto.
In questo senso si sono sviluppate numerose ricerche tendenti a verificare secondo quali modalità alcuni fattori come la carenza di cure materne (R. Spitz, J. Bowlby, E. Erikson), la disgregazione familiare (F.I. Nye, H. Rodman e P. Grams), l’assenza della figura paterna (R.G. Andry, T. Grygier), la disciplina familiare (W.Mc Cord, S. Glueck) possano contribuire alla formazione di una personalità asociale.
Qual è lo specchio della società oggi?
Nei giovani troviamo soprattutto alienazione, disperazione, minor solidarietà e deterioramento dell’integrazione sociale.
A cosa conduce la devianza? Perché è importante parlarne?
La devianza ai nostri giorni, può portare ad un aumento della violenza tra giovani, come può condurre ad un uso e abuso di sostanze (droghe, alcool, etc), carenza di autocontrollo e mancata capacità di gestione delle emozioni.
Ma esiste un rimedio. Racchiuso in una parola: Empatia.
Cosa si intende per empatia?
Rappresenta la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella situazione di un’altra persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva.
Per questo sarà importante educare all’emotività e ancor più parlare di Life skills. Le life skills corrispondono ad una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.
L’OMS ne individua 10 e possiamo raggrupparle nelle seguenti 3 aree:
- EMOTIVE – consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress;
- RELAZIONALI – empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci;
- COGNITIVE – risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero creativo.
Bisogna educare alle emozioni!
«La prima speranza di una nazione è riposta nella corretta educazione della sua gioventù». – Erasmo
Bibliografia:
Martin L. Hoffman, “Emphaty, social cognition, and moral action”
William Pithers, “New York Times”
Leo Bing, “Do or die”, Harper Collins, New York 1991
Robert K. Merton, Teoria e struttura sociale, Vol.II, Il Mulino, Bologna, 2000, ISBN 88-15-07655-7
Stanley Cohen, «Devianza». In : Enciclopedia delle scienze sociali, Vol. II (Classe-Diplomazia), Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1992, ad vocem
D. Goleman, “Intelligenza sociale”

